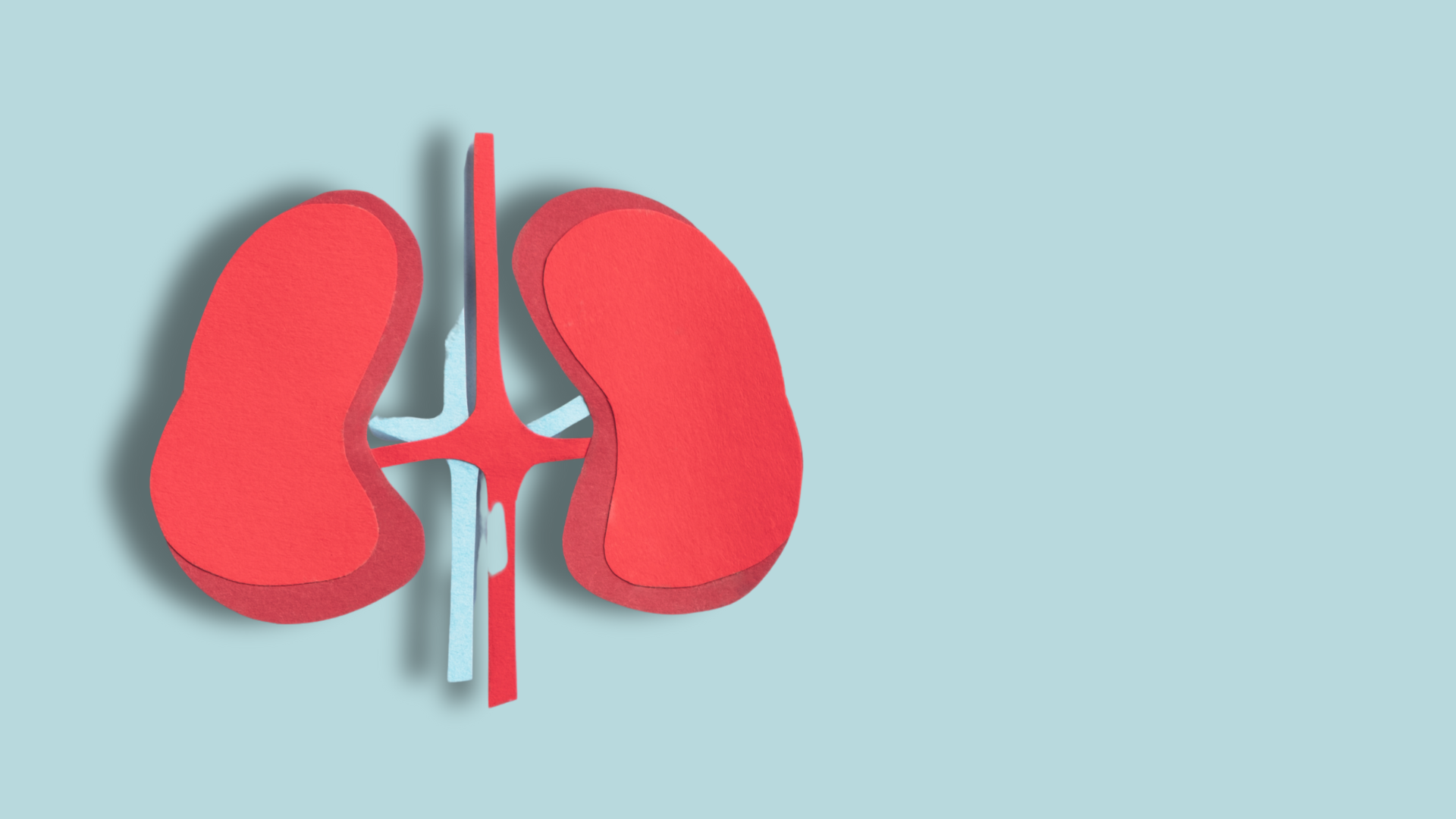Dopo i primi xenotrapianti di rene in pazienti vivi, la ricerca torna ai fondamentali: due studi pubblicati su Nature raccontano in dettaglio uno dei primi xenotrapianti di rene su un essere umano in morte cerebrale. Le analisi fisiologiche e molecolari mostrano come l’organo abbia funzionato per oltre due mesi, fornendo una mappa preziosa delle reazioni immunitarie per indirizzare sempre meglio questo tipo di interventi
Era il 2021 quando è stato eseguito il primo xenotrapianto di rene in un essere umano, cioè il trapianto d’organo da una specie diversa dalla nostra, su una donna dichiarata cerebralmente morta. Da allora, la ricerca sul campo è andata avanti velocemente e, nell’arco di appena tre anni, è stato eseguito anche il primo xenotrapianto di rene su una persona viva, seguito da alcuni altri interventi e, nel 2025, dall’inizio dei primi, piccoli trial clinici.
E, questa settimana, sono stati pubblicati su Nature due articoli che forniscono un’analisi dettagliata di quanto osservato in uno dei primi xenotrapianti di rene – uno di quelli condotti su un paziente cerebralmente morto, avvenuto nel 2023. Ma perché “tornare alle basi” e guardare i dati dei primi xenotrapianti?
Questi lavori non servono più a dimostrare che lo xenotrapianto di rene è possibile, ma riportare e condividere, in primis con la comunità scientifica, le informazioni ottenute su come funziona e come migliorarlo, offrendo dati sistematici e riproducibili. Ne riportiamo i principali.
Lo xenotrapianto di rene del 2023
L’intervento cui si riferiscono i due studi è stato guidato dal NYU Langone Transplant Institute, a oggi il centro di riferimento per lo xenotrapianto di rene, e dal Columbia Center for Translational Immunology. È stato eseguito su un paziente dichiarato morto cerebralmente e con un grave glioblastoma che rendeva impossibile la donazione degli organi, ma privo di altre malattie significative.
Il rene trapiantato, o meglio xenotrapiantato, proveniva da un maiale geneticamente modificato (abbiamo spiegato qui perché i maiali sono la specie d’elezione per gli xenotrapianti). La modifica riguardava un solo gene, GGTA1, principale causa del rigetto immediato: questo gene codifica infatti per un enzima responsabile della produzione di uno zucchero, α-Gal, che si trova sulla superficie delle cellule di quasi tutti i mammiferi, ma non negli esseri umani né nelle scimmie antropomorfe; di conseguenza, la sua presenza nell’organismo ricevente scatena una forte risposta immunitaria e il rigetto dell’organo.
Un altro aspetto importante del rene trapiantato è che non si trattava di un “semplice” rene bensì di uno “rene-timo”. In breve, sotto il rene è stato posto anche un tessuto derivato dal timo (anch’esso di origine suina), l’organo nel quale avviene la maturazione di linfociti T, che serve a condizionare il sistema immunitario del ricevente per aiutarlo a riconoscere l’organo come proprio, limitando di nuovo il rischio di rigetto.
I principali risultati dello xenotrapianto
Il primo dei due articoli appena pubblicati, a prima firma di Robert Montgomery, Direttore del Dipartimento di Chirurgia che ha guidato l’intervento, fornisce un quadro generale ma approfondito, di come ha funzionato il rene di maiale nei 61 giorni di osservazione.
La funzionalità renale si è mantenuta per tutto il periodo: lo xenorene produceva urina e ha mantenuto i parametri funzionali (creatinina e clearance) nei limiti fisiologici.
Questo, però, non significa che non vi siano state criticità nel periodo di osservazione: dopo un mese dallo xenotrapianto, infatti, vi è stata una risposta di rigetto anticorpo-mediata che ha causato infiammazione nei vasi sanguigni del rene e lesioni nei glomeruli, le strutture che filtrano il sangue. È stata trattata con successo, ma è seguita, dopo un paio di settimane, un’altra risposta di rigetto che ha colpito direttamente i tessuti del rene.
Entrambe le risposte hanno comunque risposto al trattamento, basato su plasmaferesi (per rimuovere gli anticorpi), farmaci che bloccano il complemento e immunosoppressori che riducono l’attività dei linfociti T. In questo modo, l’organo ha recuperato la funzione fino al momento dell’espianto, senza segni di danno irreversibile. Inoltre, non è stato osservato alcun segno di infezione o trasmissione di agenti zoonotici, che rappresentano un’altra importante preoccupazione nel campo degli xenotrapianti.
L’analisi molecolare e cellulare dello xenotrapianto di rene
Il secondo studio ha invece indagato più nel dettaglio la risposta molecolare e cellulare allo xenotrapianto di rene. È quella che viene definita analisi multi-omica, ossia un approccio che valuta contemporaneamente più “strati” di informazione biologica (una cellula, un tessuto, un organo o un intero organismo), raccolti a livello della singola cellula.
L’uso di tecniche avanzate di analisi ha permesso di seguire l’evoluzione della risposta immunitaria del paziente verso il rene xenotrapiantato. Di fatto, sono state analizzate le molecole e le cellule del sistema immunitario che si sono attivate nelle fasi di rigetto osservate dal punto di vista clinico, e i danni molecolari verificatisi nel tessuto dell’organo. Senza entrare nei dettagli, queste informazioni sono preziose perché suggeriscono potenziali bersagli molecolari per modulare la risposta immunitaria e migliorare la sopravvivenza dei futuri xenotrapianti. In altre parole, consente di avere una sorta di atlante molecolare del rigetto xenogenico, che aiuta a capire quali cellule, geni e vie infiammatorie sono coinvolti e quindi come prevenirle o controllarle meglio nei trapianti clinici futuri.
Questo è un tipo di analisi che non avrebbe potuto essere eseguita sui pazienti vivi, perché richiedono numerose procedure invasive che permettano di seguire in tempo reale l’evoluzione della risposta immunitaria.
Insomma, nell’indagare e condividere i risultati delle analisi condotte sui primi xenotrapianto di rene, i due lavori appena pubblicati consentono di approfondire i meccanismi di questi interventi. Per renderli così sempre più sicuri e replicabili.