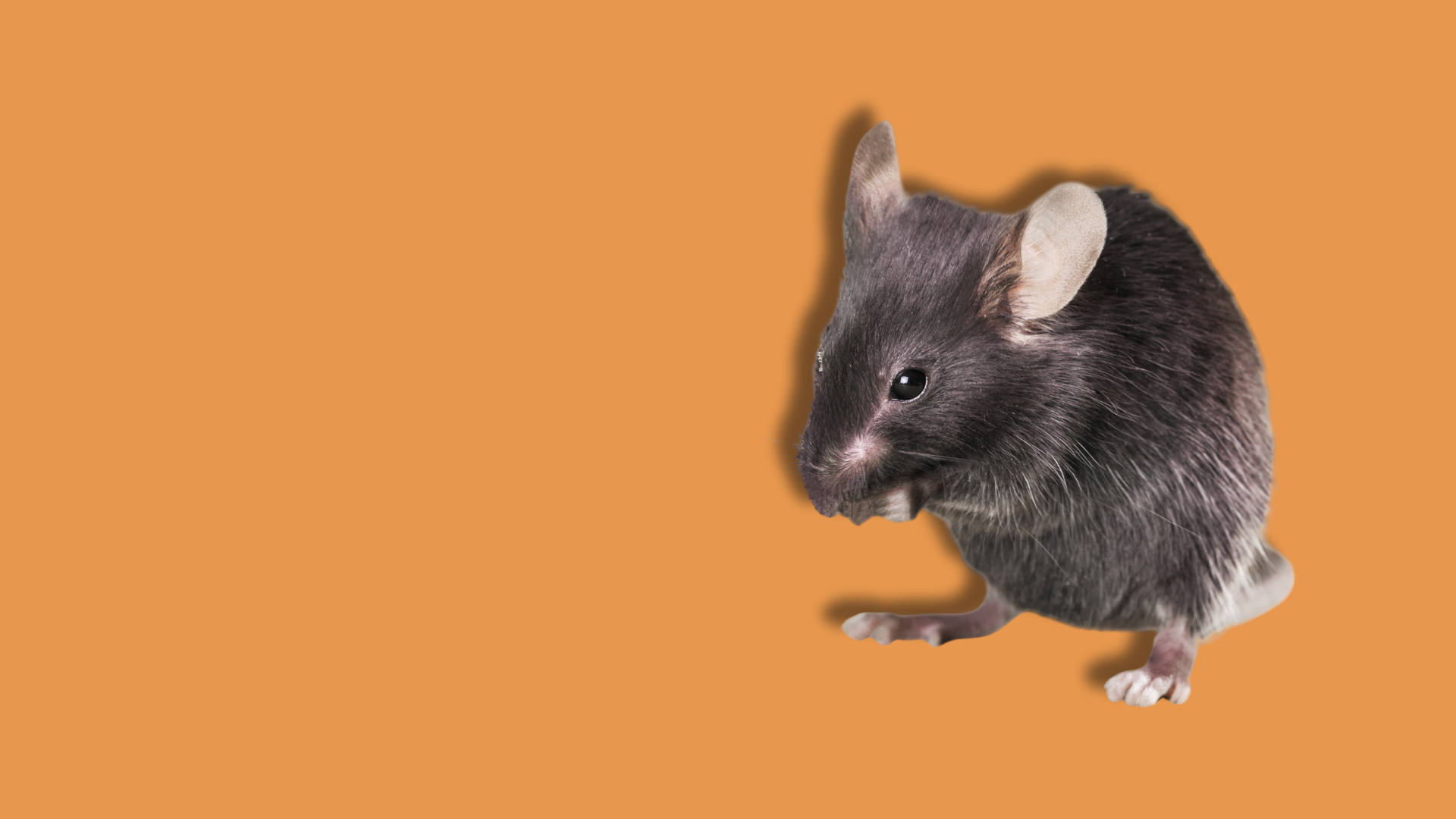Il benessere degli animali da laboratorio è una questione tanto etica quanto scientifica: garantirlo è infatti essenziale per avere risultati affidabili e ripetibili. Per questo il controllo di aspetti che vanno dalla loro genetica allo stato di salute, fino all’ambiente in cui vivono è di fatto un percorso che inizia già dall’allevamento
Ogni persona è diversa dall’altra. Ma questo vale per tutti gli animali (e organismi viventi). È la ragione per la quale, quando si progetta un esperimento che coinvolge gli animali da laboratorio, sono fondamentali alcuni controlli che permettano di assicurare al meglio la riproducibilità e la validità scientifica del lavoro, che a loro volta hanno un effetto diretto anche sul numero di animali necessari, perché eventuali bias ed errori implicano la necessità di ripetere il lavoro. Insomma, un aspetto che rientra in pieno nel principio delle 3R.
Prendiamo i topi, da sempre una delle specie più utilizzate a fini scientifici. Anche se ai nostri occhi umani possono sembrare identici, vari aspetti, dalla linea genetica, allo stato microbiologico, fino alla dieta, possono distinguerli tra loro e influenzare i risultati della ricerca. Quali controlli permettono di tenere in considerazione tutti questi parametri nel setting sperimentale?
Di fatto, si tratta di una catena di controllo che inizia già negli allevamenti. Rimanendo sempre sui topi, per esempio, gli allevamenti forniscono colonie geneticamente standardizzate, per le quali garantiscono controlli
- genetici, per esempio per le linee geneticamente modificate o inbred, cioè in cui i membri della colonia condividono praticamente lo stesso DNA;
- microbiologici, per verificare l’assenza di patogeni specifici;
- ambientali, obbligatori dal punto di vista legislativo e normati in modo preciso per garantire il benessere animale e necessari dal punto di vista scientifico per evitare stress e sofferenza psicofisica che possono alterare i risultati sperimentali.
I controlli continuano negli stabulari di università ed enti di ricerca che effettivamente usano gli animali. Di alcune delle figure tecniche e responsabili abbiamo già avuto modo di parlare qualche volta, e comprendono anche un/a veterinario/a designato/a. A loro spettano innanzitutto i controlli all’arrivo degli animali (ovviamente anche verificando la documentazione che il fornitore deve allegare), e quindi il continuo monitoraggio sia dello stato di salute fisica sia del comportamento: continua il controllo ambientale quindi, con un’attenta gestione non solo di cibo e disponibilità d’acqua ma anche di aspetti come l’arricchimento ambientale, la presenza di rifugi in cui gli animali possono nascondersi, o ancora la scelta degli individui che convivono tra loro, fondamentale non solo dal punto di vista di un’eventuale riproduzione ma anche per evitare scontri, perché le diverse specie possono avere una tolleranza molto limitata tra sessi uguali, o con individui diversi dal gruppo di origine eccetera. In questo contesto, vale anche la pena notare che l’housing standardizzato, cioè l’attenzione a mantenere tutti gli animali nelle stesse condizioni, è importante anche come ulteriore fattore di riduzione della variabilità individuale.
Naturalmente, dalla responsabilità di controllare che tutti gli aspetti siano idonei all’esperimento non è esente il/la ricercatore/trice che lo guida. E che, dunque, deve verificare che le caratteristiche genetiche e sanitarie dell’animale siano idonee alla procedura che si intende applicare, segnalare eventuali problemi che possono compromettere la qualità dei dati e collaborare con lo stabulario e l’Organismo preposto al benessere animale (OPBA) per garantire le condizioni ottimali di stabulazione.
Infine, come abbiamo già avuto modo di approfondire qui, prima che un progetto in cui si usano gli animali venga effettivamente messo in atto è necessario un percorso di valutazione che coinvolge non solo l’OPBA ma anche il Ministero della Salute. Tra le varie informazioni che possono essere richieste in questo contesto, infatti, sono comprese anche la documentazione degli animali utilizzati e i protocolli di monitoraggio sanitario e genetico.
Insomma, i controlli sugli animali, che comprendono aspetti che influenzano sia il loro benessere sia, in modo ancora più diretto, la validità dell’esperimento, rappresentano una responsabilità condivisa, che parte dall’allevamento e si deve mantenere con una gestione attenta da parte del personale dello stabulario e del gruppo di ricerca. Tutto allo scopo di fare buona scienza, che non può prescindere dalla cura degli animali coinvolti.