Farmaci, pesticidi, metalli pesanti, microplastiche e materiali avanzati: ogni giorno siamo esposti a un’infinità di composti chimici di cui sappiamo ancora troppo poco. Studiare i loro effetti solo in modelli standardizzati non basta più. Oggi la tossicologia punta a un approccio integrato, capace di unire analisi biochimiche, modelli cellulari tridimensionali e sistemi patologici per capire davvero come queste sostanze interagiscono con la biologia umana
Farmaci, micro- e nanoplastiche, materiali avanzati utilizzati in ambito industriale o biomedico, come gli ossidi di grafene impiegati nella sensoristica o nei conduttori elettrici, e i quantum dots presenti nei pannelli solari, metalli pesanti, pesticidi, additivi alimentari… La quantità di sostanze con cui noi e l’ambiente in cui viviamo entriamo in contatto quasi ogni giorno è così lunga che questa breve lista ne rappresenta a stento una microscopica porzione. Capire se sono sicuri valutandoli su modelli standardizzati oggi non è più sufficiente: serve capire come interagiscono in sistemi biologici complessi, in condizioni fisiologiche e patologiche.
Farlo è innanzitutto una questione di metodo – un metodo che valorizzi la complementarietà delle tecniche che abbiamo a disposizione per studiare la tossicologia delle sostanze. Ce lo hanno spiegato con chiarezza Luisa Diomede e Paolo Bigini, ricercatori del Dipartimento di Ricerca Biochimica e Farmacologia molecolare e parte del team, coordinato dalla stessa Diomede, del nuovo Centro di Tossicologia e Biochimica Preclinica (PreTox Bio) dell’Istituto. Un centro nato proprio con questo obiettivo: rafforzare e integrare le competenze già esistenti per lo studio delle interazioni biochimiche e tossicologiche dei vari composti sia in ambito ambientale che farmacologico.
Dall’in vitro all’in vivo
«C’è una necessità crescente, anche da parte delle industrie e delle agenzie regolatorie, di affrontare in modo sempre più rigoroso gli studi di tossicologia e capire – anche prima di un’immissione sul mercato – gli effetti delle diverse sostanze sulla salute e sull’ambiente», spiega Diomede. «Il Centro PreTox Bio, aperto quest’anno, lavora su una vasta gamma di sostanze, ma con particolare interesse per quelle ancora in fase di sviluppo. L’idea è di sviluppare una serie di approcci complementari che ne studino i meccanismi d’azione a livello esogeno ed endogeno. Non solo: ci interessano gli effetti non solo in condizioni fisiologiche dell’organismo, ma anche in quelle patologiche. Questo è un aspetto di particolare rilevanza, perché storicamente gli studi di tossicologia si concentrano sui soggetti sani – eppure sono proprio quelli con malattie preesistenti i più fragili».
La parola chiave dell’approccio è la complementarietà. Lo abbiamo visto più volte anche qui su Research4Life: avere una visione d’insieme di un meccanismo o un fenomeno spesso richiede di integrare modelli e strumenti diversi. È anche per questa ragione che quelli comunemente chiamati “modelli alternativi” alla sperimentazione animale sono spesso, in realtà, modelli complementari. Se questo è un approccio già alla base di alcuni contesti scientifici (possiamo tracciarne una similitudine con il processo di sviluppo e test di un farmaco), in altri, come appunto la tossicologia, risulta a volte meno strutturato.
In altre parole, le analisi computazionali di cui abbiamo parlato per esempio qui servono a identificare precocemente marcatori di tossicità e a selezionare le sostanze più rilevanti, ma la validazione biologica rimane indispensabile: è solo verificando le ipotesi nei modelli biologici che si può tradurre la previsione in evidenza. «L’approccio del centro, quindi, è partire da sistemi cellulari bidimensionali e tridimensionali e da piattaforme di organ-on-chip per simulare le funzioni di organi umani, fino ad arrivare a modelli più complessi come C. elegans e roditori, questi ultimi anche con patologie specifiche (epatiche, intestinali, respiratorie)», spiega Diomede.
«L’idea infatti è proprio generare una sorta di setaccio che permetta di selezionare e filtrare le informazioni prima di arrivare alla riduzione degli studi sui vertebrati, massimizzando energie e sforzi, di tempo ed economici, senza ridurre la qualità degli studi», aggiunge Bigini. «Sia per la parte in vitro sia per quella in vivo possono essere condotte diverse analisi, da quelle computazionali (volte soprattutto a identificare marcatori precoci d’insorgenza di fenomeni tossici), a quelle di imaging, di biologia molecolare e cellulare, eccetera».
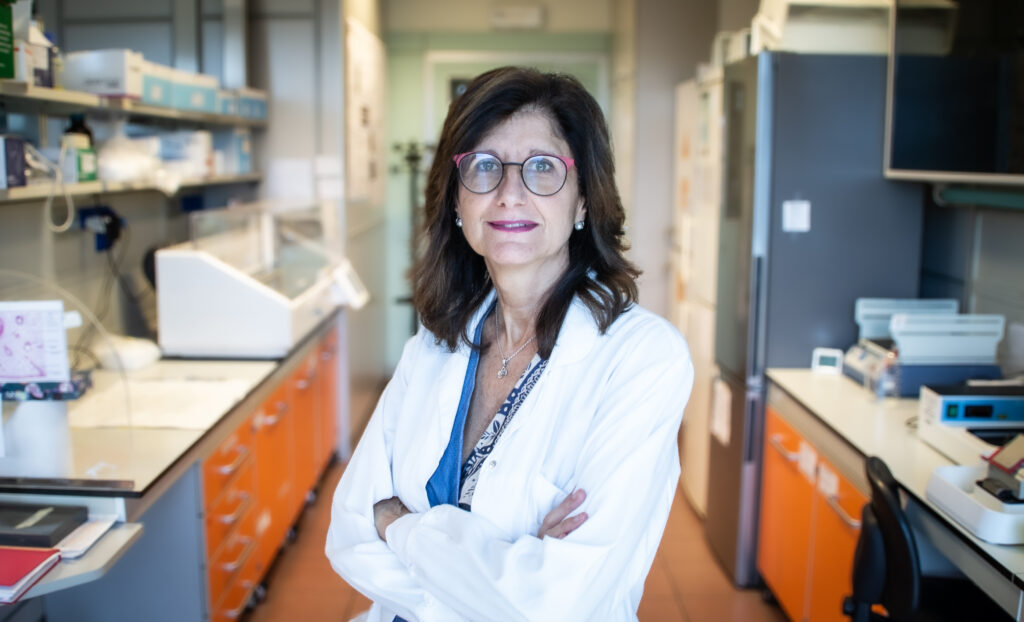

Un esempio: le nanotossicità
Un esempio di questo approccio può essere visto nel progetto europeo POTENTIAL, guidato proprio dall’Istituto Mario Negri, il cui obiettivo è proprio standardizzare il modo in cui sono analizzati i nanomateriali avanzati, materiali di dimensioni estremamente ridotte (spesso inferiori a 100 nanometri) che trovano applicazione in campi molto diversi, dall’elettronica alla medicina, ma la cui interazione con l’ambiente e con i tessuti viventi è ancora poco conosciuta. «Oggi ogni laboratorio tende a usare protocolli propri, rendendo difficile confrontare i risultati o valutarne la solidità», spiegano Diomede e Bigini. «Nel progetto lavoriamo su più livelli, che partono da protocolli condivisi per la caratterizzazione fisico-chimica e cui si affiancano nuovi metodi di imaging ad alta risoluzione, che permettono di visualizzare come le nanoparticelle si distribuiscono e si modificano quando entrano in contatto con matrici complesse, come i tessuti biologici o i sedimenti ambientali. C’è poi la parte di valutazione della nanotossicità, per la quale sfruttiamo modelli cellulari 3D, e la creazione di modelli predittivi in grado di “raggruppare” nanomateriali con caratteristiche simili, così da ridurre la necessità di ripetere esperimenti su ogni singolo materiale. Questo approccio, oltre a rendere le valutazioni più rapide e sostenibili, contribuisce a limitare l’uso di test sugli animali».
È un contesto che permette di approfondire la tossicità di sostanze ancora poco note, come potrebbero essere alcuni prodotti farmaceutici di nuova generazione, comprese le nanoparticelle vettori di farmaci e i sistemi a rilascio controllato. Ma consente di capire meglio anche quella di materiali già molto studiati e “famosi” anche a livello mediatico, come le micro- e nanoplastiche, per le quali sono oggi disponibili vari studi che ne evidenziano gli effetti tossici sulle altre specie, ma poco sappiamo di quelli per la nostra. «Sembra che la carica superficiale, più che la dimensione, determini la tossicità delle nanoplastiche», spiegano i ricercatori. «Alcuni studi suggeriscono inoltre che alcune nanoplastiche possano accumularsi nel cervello, con possibili implicazioni neurodegenerative. Questo è proprio il tipo di studio che il nostro centro mira ad approfondire in modelli patologici, invece che secondo il classico schema che coinvolge individui sani», spiegano i ricercatori.
Perché capire la tossicità non significa solo misurarne i danni, ma anche imparare a leggere le interazioni tra sostanze e organismi nella loro complessità.


